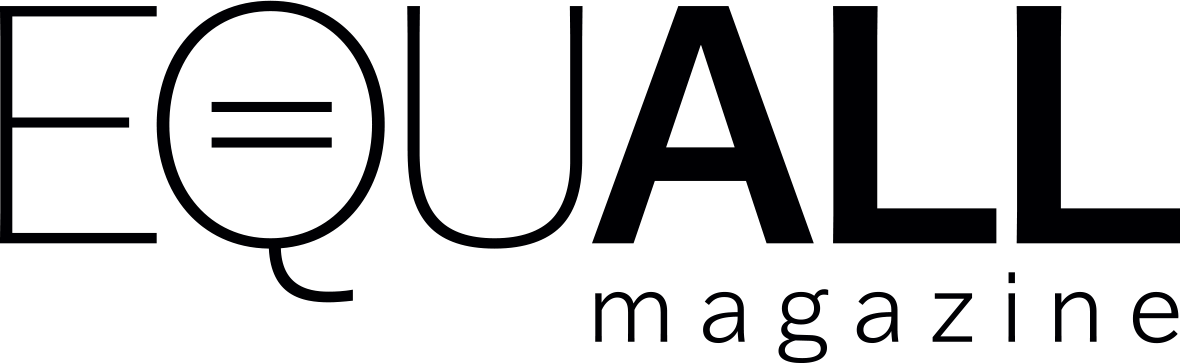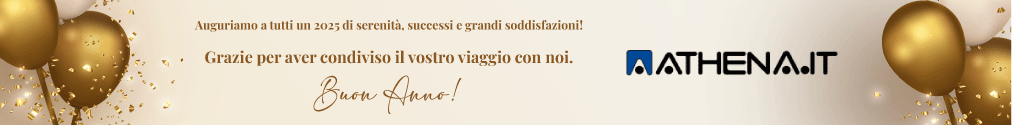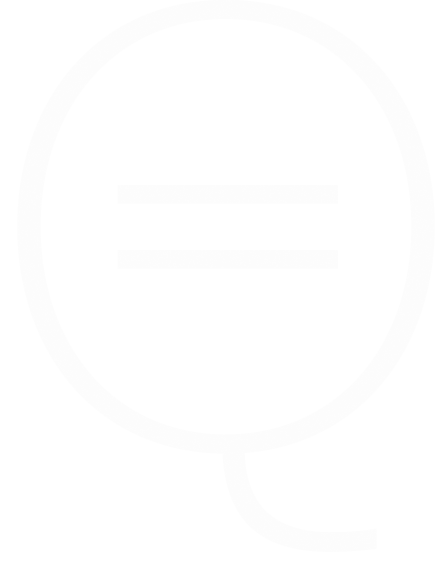AGI – Che fosse una personalità tormentata è certo, che fosse organico al sistema sovietico è dubbio, che fosse davvero un dissidente politico oltre che musicale è da escludere. Dmitrij Dmitrievic Sostakovic ha visto l’alba della vita al crepuscolo dello zarismo, il sole dell’avvenire di Lenin, la notte plumbea di Stalin, e se n’è andato a sessantanove anni il 9 agosto 1975, mezzo secolo fa, con l’aura di uno dei più importanti compositori del Novecento. Non è fama immeritata, anche se la sua carriera si è dipanata tra ombre e luci, e non certamente per i demeriti del suo ingegno, quanto piuttosto per le ingerenze del sistema sovietico sulla sua vena creativa.
Musicista eclettico che ha firmato autentici capolavori
La sua vera popolarità, al di là della cerchia di appassionati e specialisti, è arrivata con il cinema grazie a Stanley Kubrik che nel suo ultimo film, Eyes Wide Shut del 1999 con Tom Cruise e Nicole Kidman, ha rilanciato il Valzer n. 2 entrato di prepotenza nell’immaginario collettivo. Ma Šostakovič è l’autore di un capolavoro come la Sinfonia n.7 in do minore op. 60 Leningrado, che descrive in maniera mirabile l’invasione nazista, l’assedio della città e la resistenza sovietica fino alla vittoria, e la Sinfonia n. 13 in si bemolle minore op. 113 Babij Jar sull’eccidio nazista degli ebrei a Kiev nel 1941, con testi del poeta Evgenij Evtušenko.
Ed è pure l’autore del brillante e disimpegnato riadattamento orchestrale di Tea for two dall’operetta No, No, Nanette: lo fece per vincere una scommessa, e lo riscrisse in appena 45 minuti invece che in un’ora, chiamandolo Tahiti Trot. Tormentato lo fu perché fu costretto dal regime stalinista a penose autocritiche agli attacchi dell’Unione dei compositori sovietici che tutti insieme non valevano un briciolo del suo genio, e anche ad alzate di dita da parte del dittatore georgiano, il quale comunque lo teneva in alta considerazione affinché fosse strumentale alla politica del Cremlino.
L’epoca staliniana tra applausi e censure
Dopo la Rivoluzione del 1917 dalla Russia erano andati via Igor Stravinskij, Sergej Rachmaninov e Sergej Prokofev. Poi Prokofev era tornato definitivamente con la famiglia agli inizi degli Anni ‘30 e in qualche modo si era guadagnato l’intoccabilità per la fama conseguita all’estero, mentre il pietroburghese Sostakovic si era rivelato diciannovenne nel 1926 col successo della Sinfonia n. 1, che dopo la prima entrò stabilmente nel repertorio delle grandi orchestre e delle più celebrate bacchette internazionali. Quella era l’Unione Sovietica di Stalin, e un conto era l’ispirazione musicale e un conto l’ispirazione del partito e del suo signore supremo.
La sua opera Il naso su testi di Gogol’ presentata in forma ridotta ebbe subito successo, ma venne aspramente criticata dai compositori di regime e poi addirittura proibita perché tacciata di “decadentismo borghese”, qualunque cosa significhi. Allora, tanto valeva dedicare la Sinfonia n. 2 op. 14 alla Rivoluzione d’Ottobre e cercare di smussare il suo linguaggio personalissimo fatto di satira, irriverenza, persino acredine che tanto irritava gli accademici del conservatorio e i mestieranti della composizione. Il cinema sovietico si accorge subito di quel talento e le commissioni non mancano, ma non mancano neppure le consuete critiche e le censure.
I tormenti interiori e i compromessi nell’allineamento al regime
Deve allinearsi, accettare un compromesso con sé stesso oltre che col potere, perché l’Urss era il Paese dove l’Unione dei compositori, creata nel 1932, aveva deciso che il linguaggio musicale doveva essere di facile percezione e nelle partiture dovessero esserci canti popolari, inni e finali che magnificavano il socialismo. La sua seconda opera, Lady MacBeth di Mzensk, fece furore per due anni in patria e all’estero, finché nel 1936 al Bolsoj di Mosca accadde che Stalin non andò a complimentarsi con lui, e sulla Pravda uscì una feroce stroncatura, dove si diceva che quella non era musica ma caos, e anche di peggio.
L’opera venne cancellata dai cartelloni. I compositori dell’Unione fecero il tiro al bersaglio sulle sue pagine cameristiche. Era il periodo delle “purghe” staliniane, diversi amici e conoscenti erano spariti, e Sostakovic, divenuto professore di composizione al conservatorio, fece sparire la Quarta sinfonia, presentando la Quinta op. 47 come «la risposta a una giusta critica». Riuscì nell’impresa impossibile di scrivere un lavoro importante, equilibrato e potente, senza abiurare allo stile e alle idee. E fu un successo. Poco prima della guerra toccò a lui la presidenza dell’Unione dei compositori.
Dalla Sinfonia “Leningrado” al viaggio negli Stati Uniti
Poi tutto cambiò con l’invasione tedesca e nel 1941 iniziò il suo capolavoro sinfonico, la Leningrado, divenuta il monumento stesso alla resistenza al nazismo. Ce n’era abbastanza per fare di lui un simbolo dell’arte sovietica e del regime, e lo stesso Stalin nel 1949 lo spinse ad andare in America alla Conferenza di pace in un giro di propaganda. Arturo Toscanini, che pure aveva le sue partiture in repertorio, non volle però incontrarlo.
Era già deputato del Soviet Supremo, anche se non era iscritto al partito, ma negli Usa di allora questo bastava e avanzava. All’occorrenza scriveva musica di regime e di circostanza, senza mettersi al riparo da critiche velenose e strumentali. Con la morte di Stalin per lui le cose cambiarono. Nikita Kruscev non nascondeva i suoi sospetti politici e non certamente stilistici (non capiva nulla di musica), e comunque dopo i quattro Premi Stalin arrivarono anche quello di Artista del popolo dell’Urss e il Lenin. Nel 1956 verrà per la prima e unica volta in Italia, come Accademico di Santa Cecilia, riconoscimento che si univa ai tanti internazionali e al successo del suo repertorio, scremato naturalmente delle opere agiografiche.
Le contraddizioni di un artista
Solo nel 1960 si iscriverà al partito comunista, che ne aveva fatto un simbolo di eccellenza e immagine sui palcoscenici di tutto il mondo dove la sua musica veniva applaudita. Lui scrive una Sinfonia, la dodicesima, che dedica alla prima rivoluzione russa del 1905 (ma è un omaggio a Lenin). La tredicesima gli verrà l’ennesimo e ultimo attacco di stato per motivi politici, mentre in occidente vollero vederci il prodotto del dissenso alla linea del regime.
Era invece vero che la sua personalità era ormai talmente consolidata che anche il Cremlino doveva andarci cauto, e quindi erano finiti i tempi delle umilianti lettere di scuse ai compositori e al popolo dell’Urss pubblicate sulla Pravda. Nel giugno 1973, quando la salute lo stava ormai abbandonando, compì un viaggio in America su una nave da crociera sovietica, per tenere un corso all’università. Nel 1975 calava il sipario sull’uomo e sulle sue contraddizioni, ma non sulla sua musica, di duplice lettura e interpretazione, eppure di univoco fascino.