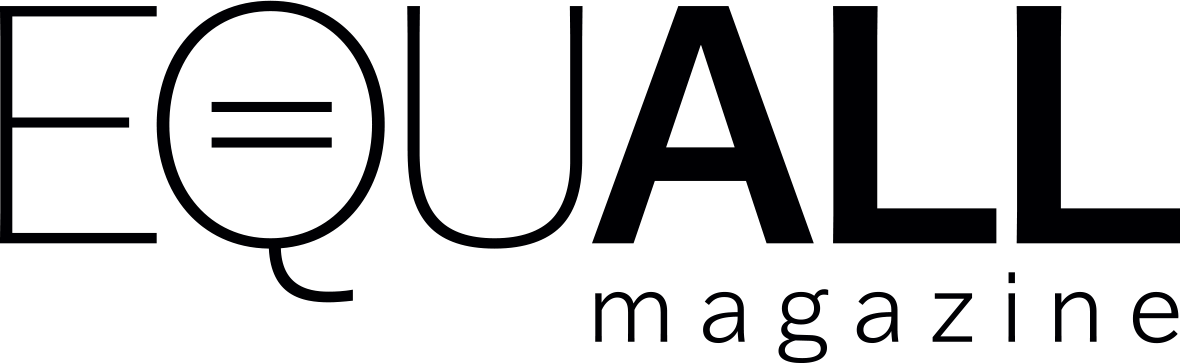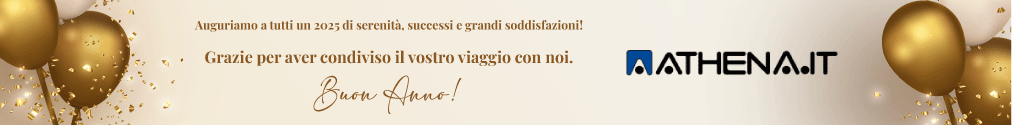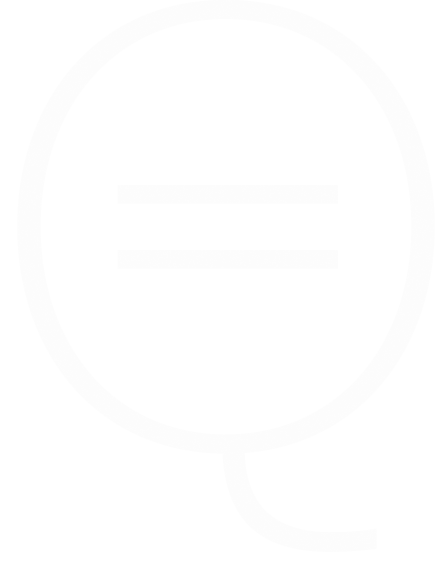AGI – Dal podio dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite il premier israeliano Benjamin Netanyahu, con una certa rudezza, ha presentato i propri successi dell’ultimo anno, ostentando una lista di nemici eliminati o duramente colpiti. L’Iran e il suo programma nucleare e di missili balistici, metà della leadership dei ribelli yemeniti Houthi, Hamas a Gaza, il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, il regime di Bashar al-Assad e le milizie in Iraq. “Tutti andati”, ha sottolineato soddisfatto.
Al netto dei toni trionfalistici del leader israeliano, e tenendo ben presente l’immane prezzo di sangue versato, in primis di civili innocenti, il Medio Oriente due anni dopo il massacro di Hamas in Israele del 7 ottobre 2023 ha un altro volto. La guerra scatenata dall’Idf nella Striscia all’indomani dell’attacco – per distruggere il gruppo militante palestinese, riportare a casa gli ostaggi e assicurare che Gaza non fosse più una minaccia, questi gli obiettivi ufficiali – ha dato la spinta al governo più di destra che Israele abbia mai avuto per ridisegnare equilibri e avanzare conquiste.
La Striscia è stata letteralmente devastata
Secondo i dati Unosat, in base alle immagini satellitari, almeno il 78% del totale delle strutture nell’enclave è stata danneggiata o completamente distrutta. In due anni di guerra, 66mila palestinesi sono stati uccisi e più di 168mila sono rimasti feriti. Oltre alle bombe su ospedali, scuole e campi profughi, così come sui giornalisti che cercano di documentare l’orrore, a Gaza si è diffusa la fame, con l’Onu che a fine agosto ha certificato la carestia.
Centinaia i palestinesi colpiti a morte mentre si accalcavano per un pacco di aiuti umanitari, che entrano con il contagocce e sono distribuiti da maggio dalla controversa Gaza Humanitarian Foundation, creatura israelo-americana che gestisce una serie di centri nella Striscia e che finora ha rivendicato di aver fornito quasi 200 milioni di pasti. A inizio anno, dopo mesi di colloqui infruttuosi, ostacolati dalle reciproche intransigenze, Israele e Hamas hanno faticosamente concordato una tregua, durata due mesi, che è stata una boccata di ossigeno per la martoriata popolazione palestinese e ha permesso il ritorno a casa di 25 ostaggi israeliani e cinque lavoratori thailandesi, oltre alla restituzione di otto corpi.
Ma a metà marzo l’Idf ha rotto il cessate il fuoco e ripreso la campagna militare e a fine agosto, nonostante l’opposizione della comunità internazionale, di una larga parte del Paese e degli stessi vertici militari, Netanyahu ha lanciato un’operazione di terra per conquistare Gaza City. L’intensità dei bombardamenti, insieme ai combattimenti, ha spinto oltre mezzo milione di palestinesi a fuggire dalla città verso la ‘zona umanitaria’ di al-Mawasi, in un esodo che entrerà nei libri di Storia.
Hamas in due anni ha perso quasi tutta la leadership nella Striscia
Compreso Yahya Sinwar, ideatore del 7 ottobre, ucciso ‘per caso’ da una pattuglia dell’Idf il 16 ottobre 2024 nella zona di Rafah – insieme a migliaia di quadri e miliziani. Non è al sicuro neanche la dirigenza all’estero, che il 9 settembre è stata presa di mira da Israele durante una riunione a Doha, uscendone tuttavia incolume. L’attacco senza precedenti dell’Idf a un Paese del Golfo, tra i principali alleati degli Usa nonché mediatore insieme all’Egitto nei negoziati, ha scioccato i Paesi arabi e musulmani ma anche Washington, e ha portato a una serie di conseguenze politiche per lo stesso Netanyahu.
Il bombardamento a Doha, e la rabbia che ne è seguita ai massimi livelli, ha paradossalmente ridato slancio all’iniziativa diplomatica condotta in primis dall’amministrazione Usa. L’inviato speciale Steve Witkoff e il genero del presidente Jared Kushner hanno colto l’occasione per mettere insieme quello che è diventato il piano in 20 punti per Gaza presentato dal presidente Usa Donald Trump. Un boccone amaro per il leader israeliano, che è stato costretto, anche se dopo aver ottenuto alcune modifiche sostanziali, a dare il suo avallo.
E dopo questo, è arrivata la seconda doccia fredda per lui, con le scuse pubbliche dovute al premier del Qatar, seguite da un ordine esecutivo del capo della Casa Bianca a garanzia della sicurezza del Qatar che ricalca l’Articolo 5 della Nato. Un unicum per un Paese arabo e uno schiaffo per Netanyahu che puntava a rafforzare l’alleanza con gli Usa e si è ritrovato con un’inedita alleanza, anche militare, tra Washington e Doha.
Il premier, secondo molti deciso a rimanere al potere a qualunque costo, in patria è pressato dalle mire espansionistiche dell’estrema destra messianica, alleata di governo, che inneggia apertamente per l’occupazione di Gaza e l’annessione della Cisgiordania, dove i coloni negli ultimi due anni hanno intensificato le violenze contro i palestinesi, tra una generale impunita’ quando non proprio aperto supporto. A questo, si aggiungono le tensioni nel governo con i partiti ultraortodossi per la mancata approvazione di una legge di esenzione degli haredi dalla leva militare obbligatoria, una questione decennale esacerbata dai due anni di guerra.
Il leader israeliano deve anche fare i conti con un Paese stanco e provato dalla guerra e dai lutti, con i familiari degli ostaggi che vedono allontanarsi sempre di più la possibilità di riabbracciare i loro cari, con una parte dei vertici della difesa che mette in guardia dal prolungarsi di un conflitto senza una strategia militare e un’opposizione politica troppo frammentata e senza una chiara leadership che non riesce a ‘mordere’ veramente, ma trova eco nelle proteste di piazza sempre più ampie e trasversali.
Gli attacchi israeliani ai nemici storici
E mentre il dramma della Striscia di Gaza prosegue sotto i riflettori internazionali ma senza che si intraveda un vero orizzonte di speranza – al netto del piano di Trump per il quale si attende ancora la risposta di Hamas – il governo israeliano negli ultimi dodici mesi ha messo a segno una serie di colpi contro i nemici storici. Il primo nella lista è l’Iran, il ‘burattinaio’ di quell”Asse del male’ che minaccia l’esistenza stessa di Israele ma anche il resto del mondo libero, come ripete sempre Netanyahu, da ultimo al Palazzo di Vetro il mese scorso. La Repubblica islamica lavora ai fianchi dello Stato ebraico, finanziando e armando le milizie sciite nella regione. I due acerrimi nemici sono impegnati da anni in uno scontro a distanza a colpi di intelligence, minacce plateali e attacchi non rivendicati. Nel mirino d’Israele c’è in primis il programma nucleare della Repubblica islamica.
Dopo il massacro del 7 ottobre e l’avvio della guerra dell’Idf a Gaza, attacchi e rappresaglie sono andati avanti per mesi, finché i due avversari si sono scontrati direttamente. Il 13 giugno Israele ha aperto le ostilità, bombardando siti nucleari, militari ed edifici residenziali nella Repubblica islamica e ha ucciso diversi comandanti di primo piano e scienziati iraniani. Teheran ha risposto con il lancio di un centinaio di missili balistici che hanno colpito Tel Aviv e Gerusalemme, facendo vittime. La guerra è proseguita con intensità per 12 giorni ed è stata segnata dall’intervento diretto al fianco dello Stato ebraico degli Stati Uniti, che hanno colpito tre siti nucleari a Fordow, Natanz e Isfahan. Per ritorsione, l’Iran ha bombardato la base militare Usa in Qatar, la più grande a stelle e strisce nel Golfo e ha sospeso la cooperazione con l’Aiea, l’Agenzia internazionale per l’energia atomica, accusandola di collusione con Israele e Usa. Lo stesso giorno, Trump ha annunciato il cessate il fuoco.
Anche Hezbollah nel mirino
L’Iran è arrivato alla guerra aperta con Israele già indebolito nella regione da una serie di colpi dell’Idf. Il primo tra gli alleati a finire nel mirino è stato Hezbollah.
A settembre 2024 l’esercito israeliano ha intensificato i raid e i bombardamenti nel sud del Libano e ha ucciso lo storico leader Hassan Nasrallah. Il 1 ottobre, lo Stato ebraico ha invaso il Paese dei Cedri scatenando una guerra in profondità contro il movimento sciita filo-Teheran, smantellandone le strutture militari nella zona vicino alla Blue Line, distruggendo gran parte delle scorte di missili e uccidendo decine di comandanti e miliziani. Devastati anche decine di villaggi, con la popolazione costretta a fuggire verso nord. Non è andata meglio nella zona sud di Beirut, roccaforte di Hezbollah, pesantemente colpita, e bombardamenti ci sono stati anche più a nord.
Dopo intensi negoziati, il 27 novembre è entrato in vigore un cessate il fuoco: l’accordo prevedeva il ritiro di Hezbollah dal sud e il concomitante dispiegamento nella regione meridionale delle forze armate di Beirut, insieme al ritiro delle truppe israeliane. Queste ultime tuttavia sono rimaste in almeno cinque postazioni nel Paese, citando necessità di sicurezza, mentre continuano tutt’ora i raid mirati contro strutture e presunti miliziani di Hezbollah. Nel frattempo, il Libano è finalmente uscito dall’impasse politica con l’elezione di un nuovo presidente, Joseph Aoun, e un nuovo premier, Salam Nawaf. Quest’ultimo di recente – sotto forti pressioni di Usa e Israele – si è impegnato a favore di un piano di disarmo di Hezbollah, la cui attuazione resta un grande interrogativo, ma che gli è già valso l’ok dell’amministrazione Trump per 230 milioni di dollari destinati alle forze armate libanesi.
Siria: il regime degli Assad si scioglie come neve al sole
Colpo di scena invece per un altro degli attori regionali, anche lui legato a filo doppio con Teheran: dopo oltre 13 anni di guerra civile, a inizio dicembre 2024 il regime siriano degli Assad, al potere da oltre cinquant’anni con il forte sostegno di Russia e Iran, si è sciolto come neve al sole nel giro di pochi giorni, sotto l’avanzata dal nord-est di una coalizione di ribelli guidata dai jihadisti di Hayat Tahrir al-Sham. Al comando, Ahmad al-Sharaa, nome di battaglia Abu Mohammad al-Jolani, fondatore del Fronte al-Nusra, ex affiliato di al-Qaeda.
Da jihadista con una taglia milionaria Usa sulla testa per terrorismo, è diventato il leader de facto e poi presidente ad interim, accolto dalle potenze occidentali, fino ad arrivare a incontrare il presidente Usa Donald Trump in suo recente viaggio nella regione e a parlare all’Assemblea generale dell’Onu a New York, primo leader siriano a prendere la parola al Palazzo di Vetro dal 1967.
Insieme all’euforia mista a preoccupazione dei siriani, in patria e all’estero, i primi mesi della nuova Siria sono stati punteggiati da violenze e massacri ai danni di minoranze, a cominciare a marzo da quella alawita, gli sciiti dalle cui fila provenivano gli Assad, con un migliaio di morti. Colpiti anche i cristiani, con un grave attentato a Damasco a fine giugno. Infine a luglio scontri e violenze si sono avute contro le comunità druse al sud, provocando anche l’intervento di Israele.
Quest’ultimo, con la caduta del regime di Bashar al-Assad, si era allargato, invadendo e occupando una zona cuscinetto nel sud. Proprio il delicato mosaico interno, la complessa situazione regionale e soprattutto l’immane compito di ricostruzione del Paese hanno spinto al Sharaa ad avviare negoziati con lo storico nemico, focalizzati in primis a trovare un accordo di sicurezza.
Nella galassia iraniana che minaccia Israele ci sono anche gli Houthi
Dall’avvio della guerra a Gaza, i ribelli yemeniti hanno lanciato ripetutamente missili e droni contro lo Stato ebraico in solidarietà con i palestinesi. Nel mirino anche le navi che transitano nel mar Rosso e nel Golfo di Aden, accusate di essere legate a Usa e Israele, con disagi per il traffico marittimo internazionale che hanno spinto già nell’inverno 2024 l’Unione europea a inviare una task force navale, l’Operazione Aspides. A ogni attacco con drone o missile – la maggior parte intercettati ma alcuni hanno colpito nel segno, in particolare a Eilat e all’aeroporto di Ramon – l’Idf ha risposto bombardando lo Yemen, soprattutto la capitale Sana’a e il porto di Hodeida. L’attacco più grave è stato sferrato alla fine di agosto e ha decapitato il governo degli Houthi, a cominciare dal premier Ahmed al Rahawi, insieme a buona parte dei suoi ministri.