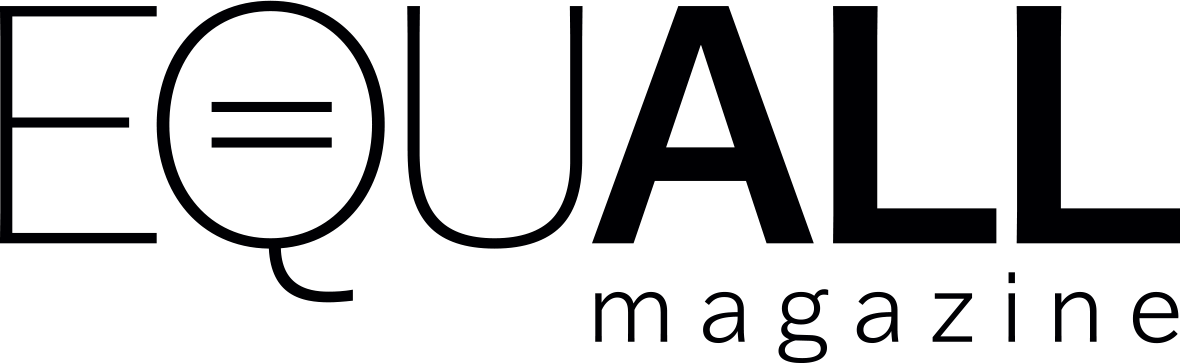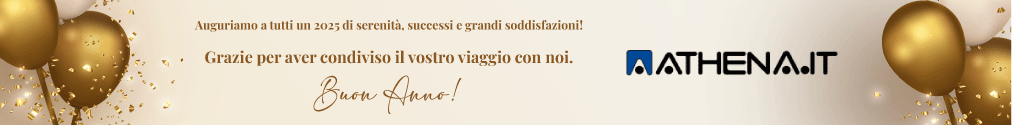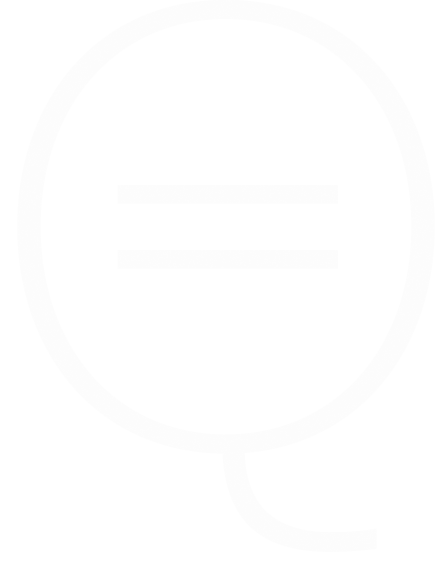AGI – Per garantirsi la tranquillità dei commerci nel Mediterraneo il Regno di Sardegna nel 1816 aveva fatto come tutti: aveva scelto di pagare i sultani di Tripoli, Algeri e Tunisi. Il tributo era meno dispendioso di una flotta da guerra da schierare contro i corsari, che peraltro non di rado issavano bandiere di comodo e continuavano a depredare le navi che capitavano a tiro. Ma a febbraio 1825 il console sardo, ammalato, era stato autorizzato a rientrare in sede per curarsi, e il suo posto era stato provvisoriamente assegnato a un vice console proveniente da Corfù.
Il bey di Tripoli Yusuf Karamanli aveva ritenuto che si trattasse invece di una sostituzione e pretese il pagamento pattuito nella convenzione del 29 aprile 1816 della somma di 5.000 piastre. Diplomaticamente il Regno di Sardegna decise di elargire mille piastre, precisando che con queste la questione andava chiusa, ma il bey reagì sequestrando tutti i beni sardi a Tripoli e il 7 agosto 1825 dichiarò addirittura guerra, sguinzagliando le navi corsare contro quelle battenti la bandiera dei Savoia.
Il re Carlo Felice invia in missione una flotta contro i corsari barbareschi
Il re Carlo Felice ruppe gli indugi ordinando all’ ammiraglio Giorgio Andrea Des Geneys, comandante generale della Regia marina sarda, di prevedere anche una tappa a Tripoli per la Regia flotto in attesa di salpare per Corfù, Alessandria d’Egitto, Beirut, Cipro, Rodi, Smirne, Dardanelli e Salonicco per accompagnare i nuovi rappresentanti diplomatici. Le navi sarde dovevano dare la caccia ai corsari ed effettuare il blocco di Tripoli, ma adoperando tutte le accortezze del caso: solo se Karamanli non fosse sceso a più miti consigli, allora si poteva ricorrere alla forza. La divisione sarda, forte nell’insieme di quasi 130 cannoni, era formata dalle due fregate Commercio di Genova (il nome dell’ammiraglia era dovuto al fatto che era stata armata proprio a spese dei commercianti) e Maria Cristina, dalla corvetta Tritone, dal brigantino Nereide e quattro unità mercantili e da trasporto, agli ordini del capitano Francesco Sivori. La flotta leva le ancore a scaglioni agli inizi di settembre e sabato 24 si ritrova al largo di Tripoli. L’indomani il Tritone si posiziona a circa tre chilometri dal molo e issa accanto alla bandiera sarda quella inglese, segnale di richiesta di colloquio con il console britannico Hammer George Warrington. E infatti la fregata viene raggiunta dai rispettivi due vice rappresentanti diplomatici ai quali Sivori affida l’incarico di riferire al bey l’intenzione di trattare. Il luogo sarà il neutrale consolato inglese. Lunedì 26 Sivori è a terra per parlamentare con il generale inviato da Karamanli, il quale si dice propenso a un accordo. Ma la sorpresa del capitano è totale quando il 27 si vede recapitare una nota del sultano di abolizione degli accordi e il rilancio anche sulle 5.000 piastre pretese, esigendone adesso 7.000. Sivori concede allora quattro ore per ritirare quella richiesta offensiva, preannunciando che trascorso quel termine avrebbe iniziato le ostilità. I tripolini neppure rispondono.
L’assalto notturno comandato dal Giorgio Mameli, padre di Goffredo
Invece di bombardare la città, Sivori decide di operare un attacco notturno a sorpresa per catturare o distruggere la flotta del bey all’ancora, protetta dalle artiglierie dei quattro forti terrestri. Nella serata di martedì 27 sulle navi sarde fervono i preparativi. Si realizzano fascine imbevute di olio combustibile, si riempiono bottiglie con acqua ragia e polvere da sparo, si selezionano le squadre d’assalto che muoveranno sulle barcacce armate di un cannone a corta gittata (carronata). Al raid prendono parte 260 uomini al comando del tenente di vascello Giorgio Mameli: il futuro padre di Goffredo, eroe del Risorgimento e autore dell’inno nazionale che porta il suo nome.
Sono stabiliti con precisione gli obiettivi di ogni barcaccia delle tre squadre supportate da diverse lance incaricate di un’azione diversiva. Alle 23 inizia l’operazione di rimorchio, che si conclude senza problemi a mezzanotte ormai passata, nonostante il fuoco di disturbo delle batterie terrestri. Il porto viene forzato nel silenzio totale, oltrepassando l’imboccatura a remi e scivolando nel buio: i marinai sardi hanno fasciato persino gli scalmi per evitare ogni piccolo rumore. Una volta oltrepassato il primo dei quattro forti, però, scatta l’allarme e da terra parte un fuoco di fucileria a casaccio, che non provoca danni. Poi scatta l’abbordaggio della prima squadra. Il primo a salire sul brigantino tripolino è il nostromo Giovanni Bottini, detto Capurro, che sarà l’unica vittima sarda. Il fuoco a mitraglia falcidia l’equipaggio nemico. La seconda squadra cattura una goletta e la dà alle fiamme, perché il vento contrario impedisce di portarla via. Alla terza le cose non vanno come previsto per l’apparizione improvvisa di una nave nemica che era rientrata di notte, ma comunque gli uomini incendiano diverse imbarcazioni e aprono ampi varchi nei soldati nemici col fuoco a mitraglia.
Successo completo con la distruzione del naviglio del bey
Tutto si conclude verso le 4 del 28 settembre, quando il previsto lancio di due razzi ordina la ritirata. Il rossore degli incendi illumina sinistramente il porto di Tripoli. Un successo completo, al prezzo di un morto e sei feriti, uno dei quali però non sopravviverà. Alte, invece, le perdite nello schieramento avversario.
Al chiarore dell’alba la squadra sarda si schiera preannunciando l’intenzione di un attacco attraverso il bombardamento. Sivori fa latore del suo messaggio a Karamanli, esortandolo a rinunciare a tutte le pretese, il capitano di un brigantino olandese che si è avvicinato nel pomeriggio per congratularsi per il colpo di mano notturno. La nave olandese torna l’indomani con a bordo il console britannico Warrington il quale porta la risposta del bey: accettazione e ripristino della validità dell’accordo del 1816.
La festa a palazzo e la cancellazione del tributo
Sul pennone del consolato sardo viene issata nuovamente la bandiera azzurra con lo scudo dei Savoia, con il rientro del console Giobatta Parodi. Sivori è invitato a palazzo dal bey, e l’invito è esteso ai suoi ufficiali. Vengono accolti con cordialità e doni. A Tripoli sono pure celebrate le esequie di Giovanni Bottini, delle cui spese si fa carico Karamanli. Quello che è ormai chiaro, comunque, è che il tributo antipirateria non sarà mai più versato. Ma il problema dei corsari non è affatto risolto. La Regia Marina, in seguito, dovrà intervenire anche a Tunisi, fronteggiare i pirati greci e ancora contro il bey di Tunisi. La pirateria sarà debellata ad Algeri con la conquista della città da parte dei francesi nel 1830 e l’anno seguente il bey di Tunisi sottoscriverà un trattato di rinuncia all’attività dei corsari, ma non sarà ancora sufficiente. Nel 1833 una flotta sarda supportata da quella del re di Napoli bombarderà Tunisi in reazione al sequestro di una nave savoiarda e la fanteria di marina sbarcherà in città chiudendo il capitolo della pirateria.