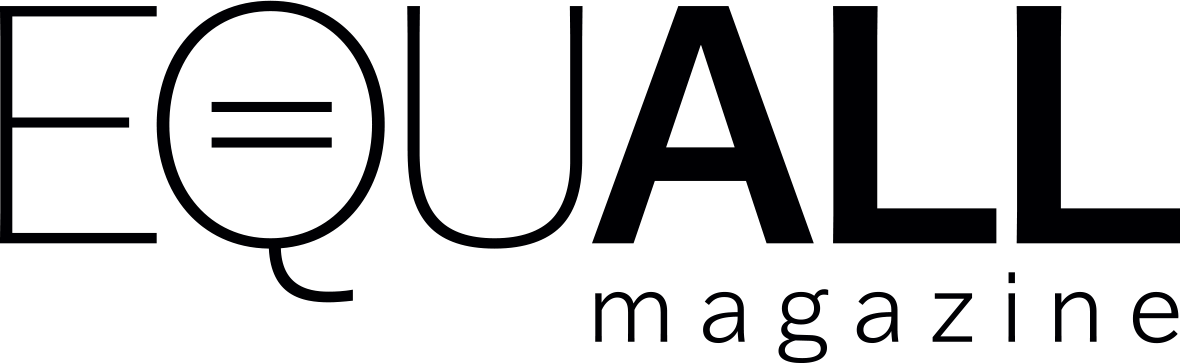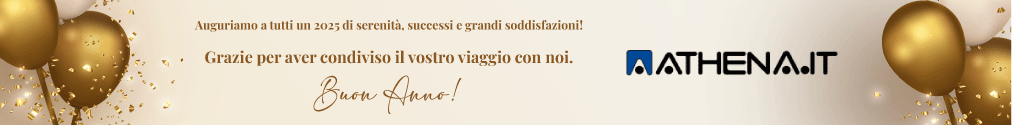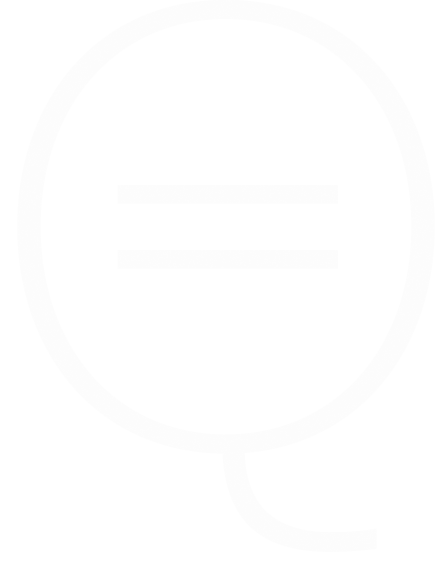AGI – La crisi climatica corre veloce sulle Alpi e non conosce confini. I ghiacciai alpini fondono a ritmi sempre più preoccupanti e la montagna diventa sempre più fragile: in sessant’anni, sulle Alpi italiane, si è persa un’area glaciale di oltre 170 chilometri quadrati, pari alla superficie del Lago di Como. Preoccupa anche la degradazione del permafrost, lo strato di terreno o roccia che resta ghiacciato per almeno due cicli stagionali consecutivi, la cui temperatura è in costante aumento. In Germania, ad esempio, entro i prossimi cinquant’anni se ne prevede la scomparsa completa, con conseguenze allarmanti per la stabilità dei versanti montuosi.
Questa la fotografia che emerge dal bilancio finale della Carovana dei ghiacciai 2025 di Legambiente e dai dati forniti dalla Fondazione glaciologica italiana, raccolti insieme a Cipra Italia durante la campagna estiva (17 agosto – 2 settembre) lungo l’arco alpino. L’osservazione ha documentato lo stato di salute di ghiacciai sempre più minacciati dalle temperature elevate, dallo zero termico in quota sempre più frequente e dagli effetti degli eventi meteo estremi, che accelerano la fusione dei ghiacci e l’instabilità dei versanti, con ripercussioni anche a valle.
Otto ghiacciai “sorvegliati speciali”
In questa sesta edizione, la Carovana ha monitorato otto ghiacciai: cinque in Italia – l’Adamello in Lombardia, il più grande delle Alpi italiane; il Ventina (Lombardia); il Solda (Alto Adige); i ghiacciai della Bessanese e della Ciamarella (Piemonte, Alpi Graie) – e tre all’estero: l’Aletsch, il “re delle Alpi”, e i ghiacciai della Zugspitze in Germania (Schneeferner e Hollentalferner). Tutti mostrano lo stesso destino: arretramento della fronte, riduzione di area e spessore. Intorno a loro, la montagna cambia profilo e colore, con ecosistemi che avanzano colmando i vuoti lasciati dai ghiacciai in fusione. Unica eccezione, il ghiacciaio tedesco Hollentalferner, che resiste ancora con sorprendente tenacia, come accade al Montasio in Friuli.
La Carovana ricorda che nelle regioni montane europee le temperature del permafrost stanno crescendo costantemente, in alcuni casi di oltre 1°C nell’ultimo decennio. Un recente studio pubblicato su Nature, dal titolo “Aumento del riscaldamento del permafrost montano europeo all’inizio del XXI secolo”, evidenzia trasformazioni più rapide e profonde rispetto al passato.
Ghiacciai sempre più neri
L’osservazione diretta, condotta insieme agli operatori glaciologici della Fondazione Cgi, ha permesso di confrontare la situazione attuale con quella del passato. I ghiacciai non solo arretrano, ma diventano sempre più neri, coperti da colate detritiche e affiancati da nuove morene. È il caso del ghiacciaio di Solda (gruppo Ortles-Cevedale), dove il Servizio glaciologico del Cai Alto Adige ha rilevato nel 2025 un arretramento della fronte di 26 metri rispetto al 2024, oltre a colate detritiche, crolli, lembi di ghiaccio morto e la formazione di rock glacier. Al contempo, boschi e nuovi ecosistemi si stanno insediando negli spazi lasciati dal ghiaccio.
Un altro esempio è il ghiacciaio della Bessanese (Piemonte). A metà Ottocento, al culmine della Piccola Età Glaciale, occupava circa 1,75 chilometri quadrati. Oggi la sua superficie è scesa a 0,3. Secondo i monitoraggi di Arpa Piemonte, tra il 2010 e il 2023 il ghiacciaio ha perso 3,9 milioni di metri cubi di volume, con un abbassamento medio di circa un metro l’anno. La fronte ha lasciato spazio a una distesa di pietre e detriti, dove si formano numerosi laghi glaciali.
Eventi estremi e instabilità
Il ghiacciaio del Ventina in Lombardia è stato segnato negli ultimi anni da piogge alluvionali che hanno intensificato le colate detritiche. Preoccupano anche i lembi di ghiaccio morto, che rendono instabile la morena laterale destra e rischioso l’accesso alla fronte attuale.
“Anche quest’anno con Carovana dei ghiacciai – ricorda Giorgio Zampetti, direttore generale di Legambiente – abbiamo portato in primo piano gli effetti evidenti della crisi climatica in alta quota. Dati ed evidenze che ci portano nuovamente a chiedere con urgenza azioni di mitigazione, puntando sulle energie rinnovabili e sulla riduzione delle emissioni climalteranti, e interventi di adattamento attraverso un piano nazionale con misure e azioni efficaci”.